Sébastien Dulude è nato a Montréal nel 1976 ed è cresciuto a Thetford Mines. Dopo aver studiato Giurisprudenza, si dedica alla letteratura, conseguendo un dottorato in Lettere all’Università del Québec a Trois-Rivières. Ha pubblicato le raccolte di poesie Chambres (2013), Ouvert l’hiver (2015) e Divisible par zéro (2019), ed è noto per le sue performance che mescolano poesia e arte visiva. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo romanzo, Amianto (edito in Italia da La Nuova Frontiera con la traduzione di Camilla Diez), ispirato alla sua giovinezza a Thetford Mines. È direttore letterario delle Éditions La Mèche e molto attivo nella scena letteraria del Québec.
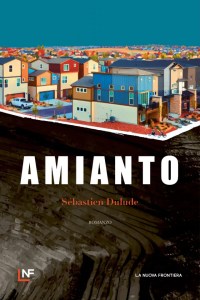
Nasci come poeta, con le raccolte chambres (Éditions Rodrigol, 2013), ouvert l’hiver (Éditions La Peuplade, 2015) et divisible par zéro (Le lézard amoureux, 2019), che speriamo di vedere presto tradotte in Italia. Cos’è per te la poesia? Che definizione, se una definizione può esserci, ne daresti?
La poesia, per me, consiste nel creare degli shock, nell’assemblare immagini ed emozioni con la massima libertà possibile, ovvero quella del linguaggio. La poesia, come la danza, è un’arte universale, fondamentale, alla portata di tutti; si tratta di incarnare la realtà in modo diverso, al di fuori dei codici, al di fuori dell’utilità.
Quando e come hai scoperto la poesia? Quali autori te ne hanno fatto innamorare?
Inizialmente sono stato attratto dalla poesia della contro-cultura del Québec e della Beat Generation americana, che risuonava bene con l’energia della fine della mia adolescenza. Poi ho esplorato i classici francesi, in particolare Baudelaire, e infine i surrealisti e le avanguardie. Ho iniziato a scrivere le mie poesie solo verso i 24-25 anni, senza sapere che vi avrei consacrato la mia vita.
La tua ricerca accademica si è incentrata sull’estetica della tipografia. In che modo la materialità del libro contribuisce alla poetica? Vale anche per la narrativa?
È un campo di ricerca che ci ricorda che tutto comincia da una percezione materiale. Il senso di un testo e le emozioni che provoca sono innanzitutto il frutto di un rapporto sensoriale con un oggetto, che ne trasmette il contenuto. Nel trasmetterlo, inietta qualcosa di sé nel testo. Solo aprendolo, prima ancora di leggerlo, un libro trasmette delle informazioni: ne riconosciamo il ritmo visivo, la densità, il tono. La poesia, attraverso le sue forme illimitate, spinge al massimo questa relazione con la propria materialità: una poesia si guarda tanto quanto si legge. Allo stesso modo, la tipografia trasmette dei valori al testo che veicola, come un umore o un colore che si mescolano al testo stesso. La pubblicità sfrutta questi valori.
I tuoi testi vivono anche sul palco. Nella tua esperienza come si influenzano performance e poesia?
Anche in questo caso, c’è un legame con la materialità del testo. Ho iniziato a creare delle performance per dare alle poesie uno spazio di significato. Recitando le mie poesie attraverso le azioni del corpo, sforzi che tingono la mia voce e il mio respiro, le poesie si caricano di un’ulteriore emozione corporea. La poesia si dispiega nel luogo e nel momento della sua performance, sul e attraverso il mio corpo; quel luogo, quel momento, il mio corpo e il pubblico di fronte ad esso diventano parte della poesia, di questa iterazione particolare, unica e irriproducibile della poesia.
Un altro elemento che gioca un ruolo importante nella tua poesia è l’immagine. In chambres i testi sono giustapposti agli scatti di Benoît Paillé. In che modo la fotografia dialoga con i versi? È un’integrazione, una chiosa, una documento?
Come per la performance scenica, chambres è stato concepito per offrire al lettore un’esperienza visiva e testuale simultanea. L’impatto tra le fotografie di azioni eseguite dal mio corpo e i miei poemi scritti crea, in un certo senso, il vero poema: un’opera ibrida.
In Italia la poesia ha pochi lettori. In Canada qual è il rapporto tra la poesia e il grande pubblico?
Deve essere abbastanza simile in Canada e in Italia: è una letteratura minoritaria, percepita come riservata agli iniziati, quasi assente dai media di massa. Tuttavia, nel Québec, la poesia ha avuto un ritorno di popolarità verso l’inizio degli anni 2010, uno slancio di vitalità che ha avuto ripercussioni persino in Francia, in Belgio e nella Svizzera francofona. Anche se affermo che la poesia è universale e accessibile a tutti, non voglio dire, né mi auguro, che debba diventare un’arte di massa. L’importante è che ognuno possa scoprire quale poesia lo tocchi, gli parli.
In quanto autore, accademico e direttore editoriale, cosa puoi dirci della letteratura canadese? A tuo parere cosa la distingue e cosa la avvicina alla letteratura statunitense e a quella europea?
Domanda immensa! Innanzitutto bisogna notare che il Canada ha due realtà letterarie, piuttosto isolate l’una dall’altra: quella anglofona e quella francofona. A questo terreno bisogna aggiungere le letterature di lingua autoctona, spesso orali, e ancora poco note. Tutto ciò formerebbe la letteratura canadese. Che cosa avrebbero in comune? Certamente un rapporto con il territorio, con lo spazio, che è condiviso anche dalle altre letterature nordamericane. Forse anche una certa libertà, una certa freschezza, una certa mancanza di complessi dovuta alla maggiore distanza dalle letterature classiche europee. Forse.
Recentemente hai “traslocato” dalla poesia alla narrativa. Come è avvenuto questo passaggio? La tua prosa ha mantenuto elementi poetici e performativi?
Dato che pratico il mestiere di editore letterario da nove anni e che leggo da sempre, il romanzo è un genere che mi è molto familiare. Avvicinandomi ad esso con Amianto, ho conservato della poesia il gusto per il vocabolario polisemico, vibrante di possibilità. La struttura in ellissi temporali ha forse a che fare anche con la mia fascinazione per il silenzio tra le poesie, nel quale il lettore è invitato, in piena libertà. Penso anche che le descrizioni sensoriali dei paesaggi e l’attenzione rivolta alle sensazioni fisiche dei personaggi derivino dalla mia associazione naturale tra la scrittura e il corpo.
Il tuo primo romanzo, Amianto, racconta Thetford Mines, la città dell’“oro bianco”, il tuo paese natale. Come è nata l’idea di questo libro? Come hai trasposto gli elementi autobiografici nella storia?
Il tema dell’infanzia e dell’amicizia mi ha destato l’interesse – non ricordo più esattamente né quando né perché. La poesia non sembrava potermi offrire la possibilità di esplorare una relazione d’amicizia infantile (l’altro è sempre molto assente nella poesia, almeno nella mia), e rendendomi conto che stavo per creare due personaggi, Steve e il piccolo Poulin, è stato naturale per me collocare la loro amicizia nel luogo, molto speciale, in cui sono cresciuto, e sullo sfondo della mia stessa infanzia. Ho utilizzato una grande quantità di materiale autobiografico, ma rielaborato, spostato, trasformato per la finzione, per la trama narrativa che ho intravisto. In questo senso, Amianto non è un’autofiction, poiché la sua affidabilità biografica è molto instabile. Rivendico tranquillamente che Steve Dubois mi somigli molto, ma ciò che vive è una costruzione, una storia. Invece, l’impatto che una città mineraria di amianto ha sulla vita dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie è ben reale, e questo aspetto è stato un motore di intenti per la scrittura del romanzo.
Il protagonista, Steve, un bambino di nove anni dotato di una grande sensibilità, deve mettersi in salvo dal padre severo e autoritario, che vorrebbe fare di lui un uomo duro e insensibile. Altrettanto importanti sono il fratello Daniel, il prediletto perché conforme alle aspettative paterne, e la madre, spesso assente. In che modo hai voluto raccontare le relazioni familiari?
Ho voluto raccontare come, dalla prospettiva di un bambino fragile e molto sensibile, un ambiente familiare non rassicurante e un contesto sociale e geografico insicuro potessero influenzare negativamente il passaggio dall’infanzia all’adolescenza.
Un’altra forza salvifica per Steve è l’amicizia con il vitale e immaginifico Poulin. Nella novella Il corpo, che per certi versi può essere accostata al tuo romanzo, Stephen King scrive: «Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni.» Sei d’accordo?
Adoro questa citazione. Penso effettivamente che le prime grandi amicizie siano occasioni per scoprire se stessi, al di fuori dello sguardo dei genitori e parzialmente ai margini dei discorsi sociali che ci attraversano. L’amicizia è un atto di pura fiducia nell’alterità, e il teatro di innumerevoli apprendimenti, scoperte e, naturalmente, di disobbedienze! È anche intrinsecamente creativo: bisogna creare la relazione, lasciarsi trasportare dalla complicità con l’altro.”
Un elemento di grande forza del romanzo è il paesaggio, dicotomico, in cui coesistono gli scenari lunari e alieni delle miniere e la bellezza selvaggia della foresta. Può essere definito un personaggio autonomo?
Era proprio il mio desiderio! Il paesaggio agisce sui personaggi, ma nel caso di una miniera si tratta di una presenza imponente, poiché la si sente continuamente, se ne percepiscono le vibrazioni 24 ore su 24, 6 giorni su 7. Per fortuna c’era la foresta, anch’essa costituita da stimoli costanti, dove poter trovare la sensazione di fuggire.
L’album delle catastrofi di Steve e Poulin, in cui compaiono i disastri dello Space Shuttle Challenger e di Chernobyl e a cui si aggiungerà, fatalmente, un’altra tragedia, rappresenta in parte una profezia inconsapevole e in parte un tentativo di esorcismo. Proietta inoltre la vicenda personale in una dimensione universale. Oggi quali tragedie inserirebbero i due ragazzi nel loro album? È possibile a tuo parere esorcizzare i tempi tragici che stiamo vivendo? La letteratura può avere un ruolo in questo?
Ciò che è “interessante” delle grandi catastrofi è come esse marchino collettivamente e in modo inatteso, a differenza delle lunghe guerre, per esempio, che si installano in una durata e diventano, purtroppo, una realtà quotidiana. Le catastrofi improvvise, sconvolgenti, ci ricordano che l’impensabile può sempre accadere, senza preavviso. Mentre scrivo queste righe, siamo all’indomani dell’odioso assassinio di Renee Nicole Good da parte di un agente della milizia anti-immigrazione ICE, negli Stati Uniti. Davanti alla violenza di questa notizia, al sentimento generalizzato di insicurezza vissuto dagli statunitensi a seguito di questa inqualificabile macchia, non credo che la letteratura possa farci granché, se non consegnarla alla memoria, per rimettere in scena la situazione, esaminarla, darle un racconto che si possa condividere, per curare, prevenire, indignarsi. Questo omicidio esiste, rischia di far precipitare un paese in una divisione civile senza precedenti, e non si esorcizza. Lo si può solo subire. Per tornare ai due bambini di Amiante, la loro fascinazione per le tragedie è forse analoga a quella per i film horror; con una certa distanza, gli articoli di giornale permettono di dare un nome al pericolo e di addomesticare la paura. Ma permettono anche di collocarla e, a seconda della sensibilità di ciascuno, la minaccia sembra più o meno lontana.
È stato detto che Amianto descrive il «sogno americano operaio in declino». Cosa resta oggi, a tuo parere, del sogno americano? È possibile coltivarne uno alternativo?
Il Canada moderno, ancor più degli Stati Uniti, si è costruito a forza di estrarre dal proprio sottosuolo, deviare fiumi, far esplodere montagne; insomma, dominando la natura. Attingere dal sottosuolo un materiale cancerogeno (e nascondere tali fatti ai lavoratori e agli acquirenti) per accumulare profitti economici è un sintomo tra i tanti della psicosi capitalista: arricchirsi per vivere meglio, ma morire per riuscirci.
Di fronte all’isolamento Steve trova rifugio nei libri e nella musica. In che misura la cultura può essere un mezzo per sopravvivere al disagio e al trauma?
L’arte è un rifugio interiore, una casa nella quale esplorare le proprie emozioni, rimettere in scena determinate situazioni, riorganizzare la realtà. Credo molto nel potere rigeneratore dell’arte.
Grazie a Gianluca Cataldo (La Nuova Frontiera) e a Martina Berardi per la supervisione linguistica.






Lascia un commento